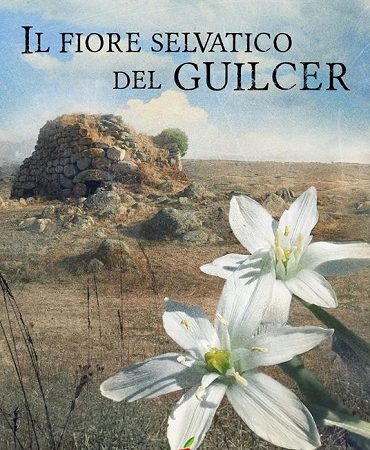Il dono
Alle 19.00 giunse non più sperato l’invito. Imbarazzato, forzato e non formale, diretto e non immediato. Ma bastava, suonava come una campana, un concerto di sveglie, un allegro di Mozart. Scendere a un’ora dalla chiusura dei negozi era la sfida a cogliere impreparati, per arrivare al pranzo del giorno di festa con un dono. Non sotto casa, non c’erano i negozi giusti, in centro. Via di corsa – sì sono guardabile – il posteggio, la signorina gentile, l’oggetto. Bello inutile e delicato, un gioiellino formato fiore. Costava, ma di meno non era il caso e poi non c’era tempo per cercare. Qualcosa per non pensarci più se lo sarebbe inventato. Puntuale, alle due per il pranzo, col sorriso pronto, di casa nella mente, ospite nell’incedere, collo alto e stivali, studiati come se potesse scegliere fra altro. C’era freddo in una casa riscaldata, parsimonia di parole nell’abbondanza che non saziava. Prima di salire si era scrollata di dosso la discesa al reparto di terapia intensiva, dall’altra parte delle città. I residenti erano un dispetto della morte, mentre la vita se ne stava buona buona nei rumori sordi di fili e macchinari inaccessibili, per concederle la prima battuta e vederla andar via dalla sua postazione invisibile. Confrontò silenzi e stati d’animo, non volendo. Puntava sul suo giro di partecipazione attiva. Il regalo scartato fu appena guardato. E finalmente lo scatto. La signora della cerimonia si dileguò e in un fremito ricomparve. “Metti le mani qui”. Una polvere impalpabile, fredda, setosa, ondeggiava come oro in una ciotolina. Proveniva dalla fabbrica di quel dono, ricordo di un viaggio all’altro capo della geografia. Come portare una mela in un frutteto. Tutto il resto le apparve di spalle e lei senza far rumore andò via